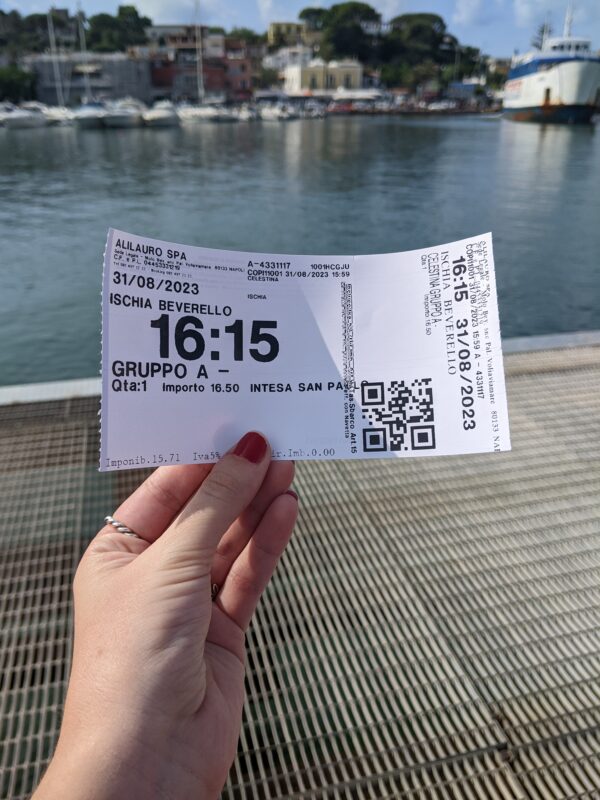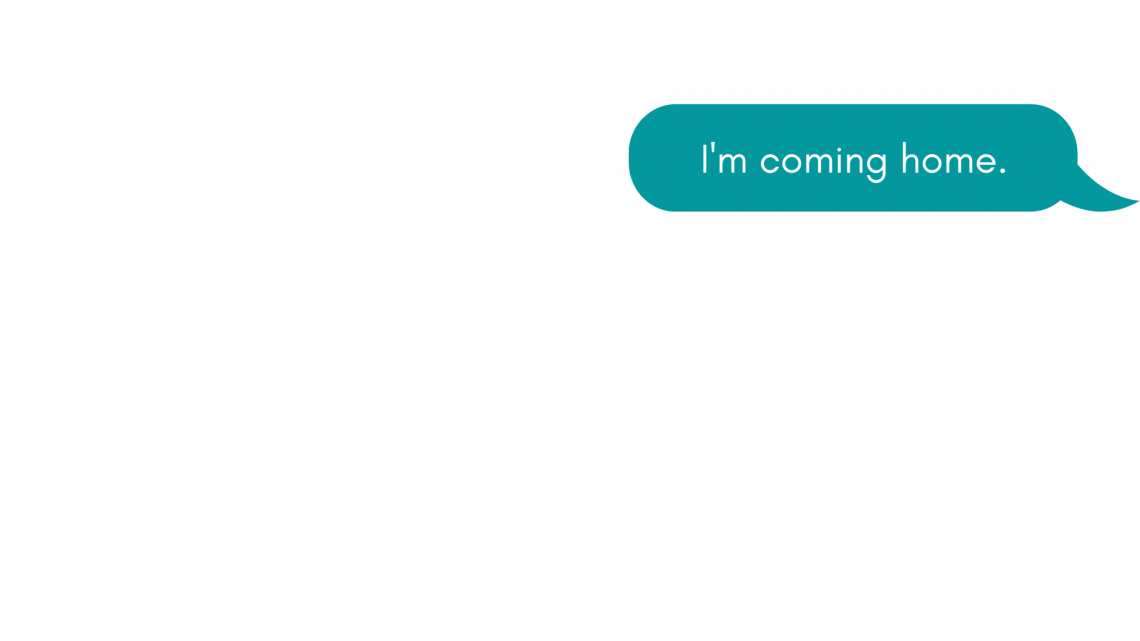Quando ero molto piccola, mi raccontano, un giorno osservando il mare dissi ai miei genitori: “Ho inventato una poesia. Ondeggia, ondeggia“. I miei genitori ne furono colpiti e mi lodarono molto. Io stessa, alla luce dei miei studi, riesco a cogliere un che di poetico in quella operetta naif.
Fatto sta che, dopo qualche minuto, evidentemente galvanizzata dall’entusiasmo mostrato dai miei genitori, esclamai: “Ho inventato un’altra poesia. Ombrellone, ombrellone“. E no. Mia madre stroncò sul nascere quel susseguirsi di ‘Sdraio, sdraio’, ‘sabbia, sabbia’, ‘paletta, paletta’ che avrei inevitabilmente prodotto. Ondeggia, ondeggia aveva davvero qualcosa di poetico, Ombrellone, ombrellone, no. Non era altro che un misero tentativo di replicare la bellezza, per provare a ottenere le stesse lodi ricevute la prima volta.
Mi è tornato in mente questo episodio osservando il catalogo delle innumerevoli piattaforme di streaming alle quali sono abbonata. Negli ultimi anni è stato tutto un tentativo di riportare in vita serie cult che hanno fatto la storia negli anni Novanta-Duemila. Il tutto accompagnato da articoli dai titoli sensazionalistici che annunciano la reunion del cast di tale serie o l’assenza di tale attrice, e che si nutrono della nostalgia che noi tutti abbiamo di quelle serie che hanno accompagnato le nostre vite.
Parlo dei molto discussi rifacimenti dei cartoni Disney, di How I met your father (che si ricollega – solo nel titolo e nella struttura a cornice, ad essere onesti – ad How I met your mother) oppure a And just like that, che riprende le fila dell’iconico Sex and the City. O ancora ai diversi prequel, sequel, spin-off.
E così noi, inguaribili romantici, ci proviamo. Cerchiamo disperatamente di appassionarci. Amiamo vedere di nuovo sullo schermo i nostri attori preferiti, anche se con qualche ruga in più. Ma la speranza di ritrovare l’antica magia, quella che ci aveva fatto battere i cuori nella nostra giovinezza, ci abbandona lentamente, lasciando il posto ad una delusione forse anche peggiore della tristezza che aveva accompagnato il finale di stagione e che stavamo ancora cercando di elaborare.
È vero che nulla si crea dal nulla. Che la scrittura è riscrittura, che la composizione – come mi ha illuminato un collega di musica – si chiama così perché consiste nel comporre, nel mettere insieme, elementi che già esistono nella nostra memoria. Ma, fatte le dovute eccezioni di prodotti effettivamente ben riusciti e che adoro, credo che oggi siamo circondati di pallide imitazioni di opere d’arte, fantasmi di un passato glorioso che per forza di cose non può più tornare, di Ombrellone, ombrellone, che non hanno più nulla di Ondeggia, ondeggia.
Mi chiedo, allora, perché ci troviamo in questo impasse. Forse perché la nostra fantasia è arrivata all’esaurimento come la batteria dei nostri smartphone alla fine di una lunga giornata? O forse preferiamo percorrere una strada sicura, già spianata da chi ci ha preceduto, piuttosto che avventurarci per un sentiero mai battuto?
Più probabilmente ciò accade perché, una volta ottenuto del consenso, abbiamo bisogno di riceverne altro. E pensiamo che applicando la stessa struttura, con qualche minima variazione di tema, possiamo riuscirci con il minimo sforzo. Forse dovremmo invece metterci in pace con l’idea che la bellezza non è replicabile come un qualsiasi prodotto di massa. Che le cose di qualità sono poche e rare, in mezzo al marasma di mediocrità che ci circonda e che contribuiamo anche noi a formare per la maggior parte del tempo.
Oggi – dove tutti scrivono libri e scattano fotografie e cantano canzoni – è ancora più difficile individuarle. Affinare il nostro fiuto, manutenere il nostro radar, diffidare dalle imitazioni è l’unico modo che abbiamo per riuscirci.